
Ragusa Sottosopra
n.6 del 30/12/2009
Chiesa di S.Giuseppe verso il restauro
a cura degli arch. Giovanni Giavatto e Carmela Maggiore (progettisti)
 Nell’ottobre scorso l’aggiudicazione dei lavori.
Nell’ottobre scorso l’aggiudicazione dei lavori.Inizialmente il progetto nasceva come “lavori di recupero e restauro conservativo del Convento delle Benedettine a Ragusa Ibla”. Poi diventa progetto di variante spostando l’intervento esclusivamente sulla chiesa di San Giuseppe bisognosa di opere urgenti di restauro sia all’interno che sul prospetto
La nascita della chiesa di San Giuseppe di Piazza Pola in Ragusa Ibla è legata alla fondazione del monastero benedettino di San Giuseppe. Non si può parlare, difatti, del monumento senza fare riferimento al monastero benedettino confinante, fondato nel 1588 ad opera di Carlo Giavanti, barone di Buxello e Saccubino che fece erigere sulle proprie case “un monastero di Montevergine sotto il titolo di San Giuseppe”. Queste proprietà confinavano con tre strade pubbliche: Piazza Maggiore (oggi Piazza Pola), via San Michele (oggi via Torrenuova) e via San Tommaso, oggi non più esistente. La committenza fu affidata a due fideicommissari che avevano il compito di costruire il monastero ed una chiesa annessa di San Giuseppe (posta a fianco del convento, nei locali dove oggi ci sono gli uffici comunali a lato di via Orfanotrofio). Benché il complesso era già stato realizzato a fine '500, fu solo nel 1611, dopo la morte del Giavante avvenuta nel 1606, che vi si stabilirono le monache di clausura. Durante il sec. XVII, il monastero e la chiesa ebbero tempi di crescente splendore, raggiungendo la comunità monastica il considerevole numero di 44 professe oltre le converse e le novizie. Il terremoto del 1693, che scosse la Sicilia orientale, fece crollare sia il monastero che la chiesa. La comunità monastica si disperse e le poche religiose rimaste si adattarono a continuare la vita monastica. Fecero costruire una baracca di legno in cui abitare ed una “cappilletta di pietra a sicco”, con funzione di chiesa in attesa di poter restaurare i fabbricati distrutti. Si dovette attendere il 1720, anno in cui tre monache professe, mandate nel monastero dal vescovo Asdrubale Termini, si adoperarono alacremente recuperando i capitali perduti nel terremoto, mettendo ordine nei conti ed iniziando la ricostruzione del fabbricato monastico e della piccola chiesa. La ricostruzione della chiesa, che sorgeva a fianco del monastero, avvenne verso il 1730; venne riedificata sulle macerie del terremoto e resa più maestosa dall'aggiunta di un fastoso “cappellone di bell'intaglio con nicchie e statue ai lati e con una vaga disposizione di otto colonne”, completato nel 1732 dal capomastro ragusano Carmelo Cult
 raro. Di queste opere non è rimasto niente, perché la chiesa fu demolita successivamente “trovandosi la detta chiesa assai malriuscita poiché è assai malamente rifatta doppo il terremoto.” Nel 1756 si comprano i ruderi della chiesa di San Tommaso per costruire la nuova chiesa (quella attuale di San Giuseppe), destinata a sostituire quella a fianco del monastero. I lavori iniziarono nel 1759. Notizie certe su chi sia stato il progettista non ne sono emerse nonostante le tante ricerche storiche condotte da esperti di storia locale. A ciò non è riuscito neanche uno dei maggiori studiosi della chiesa, il dott. Giuseppe Antoci, autore del libro “Il monastero e la chiesa di San Giuseppe”, di cui questa descrizione ne riporta alcune trascrizioni. Solo ipotesi e deduzioni, interessanti e degne di considerazione per certi aspetti, ma che non sciolgono dubbi ed incertezze.
raro. Di queste opere non è rimasto niente, perché la chiesa fu demolita successivamente “trovandosi la detta chiesa assai malriuscita poiché è assai malamente rifatta doppo il terremoto.” Nel 1756 si comprano i ruderi della chiesa di San Tommaso per costruire la nuova chiesa (quella attuale di San Giuseppe), destinata a sostituire quella a fianco del monastero. I lavori iniziarono nel 1759. Notizie certe su chi sia stato il progettista non ne sono emerse nonostante le tante ricerche storiche condotte da esperti di storia locale. A ciò non è riuscito neanche uno dei maggiori studiosi della chiesa, il dott. Giuseppe Antoci, autore del libro “Il monastero e la chiesa di San Giuseppe”, di cui questa descrizione ne riporta alcune trascrizioni. Solo ipotesi e deduzioni, interessanti e degne di considerazione per certi aspetti, ma che non sciolgono dubbi ed incertezze.L'incarico affidatoci ha portato a delle straordinarie e suggestive scoperte in fase di rilievo, riguardanti sia il complesso monastico che ancor di più la chiesa. Si è scoperto infatti che sotto i locali confinanti con l'abside vi sono spazi interrati che sarebbe interessante portare alla luce per scoprirne la reale estensione ai fini di una visione storica e costruttiva del complesso. Le attente e scrupolose operazioni di rilievo planimetrico, in particolare della chiesa di San Giuseppe, e le osservazioni e considerazioni che ne sono seguite hanno permesso di avanzare una ipotesi circa la genesi della sua particolare forma planimetrica, concepita come un “unicum” con le semplici, morbide e quasi riservate e senza imponenza, “gradonate” di ingresso poste nel sagrato. A noi è sembrata straordinaria la supposizione che la costruzione della chiesa si sia basata su un tracciato planimetrico che risponde ad un disegno ben preciso, anche se non se ne hanno notizie e documentazioni, per il rigore geometrico semplice cui obbedisce. Se il disegno planimetrico non è di un architetto, è di sicuro “frutto” della collaudata esperienza di mastri, capimastri e direttori. Come afferma il prof. Marco Rosario Nobile “i tesorieri contabili e i capimastri erano responsabili della lettura ed interpretazione dei disegni di fabbrica forniti dall'architetto”. Nel 1775, demolito il campanile di San Tommaso (il cui orologio fu rimontato nella facciata del duomo di San Giorgio appena completata), vengono innalzate le “fabbriche” della chiesa di San Giuseppe, già a buon punto essendo state completate le decorazioni scultoree del primo ordine della facciata. In questo stesso anno (1775) lo sculto
 re Giambattista Muccio viene pagato per aver scolpito i sei capitelli delle colonne e le “statue grandi di San Benedetto e San Mauro e quelle mezzane di Santa Geltrude e Santa Scolastica”; mentre mastro Paolo Cultraro di Scicli veniva pagato per i due vasi barocchi posti dietro le statue grandi. Nel novembre del 1775 un altro sciclitano, artigiano Filippo Scattarelli, viene incaricato di costruire la grata panciuta in ferro battuto, “da situarsi nel finestrone della nuova imperfetta affacciata sopra la porta maggiore della chiesa”. Il bel prospetto veniva completato con l'aggiunta della cella campanaria a tre luci sormontata da una cuspide che porta la croce, probabilmente nel 1783, anno dell'ultimo pagamento fatto a mastro Giambattista Muccio “per il novo edificio della chiesa di detto Monastero”. Nel 1785 don Domenico Monelli, procuratore del Monastero, incarica mastro Mario Occhipinti di portare nella nuova chiesa “tutta quella pietra di tufo necessaria per lo dammuso”. Inizia la costruzione della grande volta a padiglione, “il dammuso”, a copertura della navata ovale della chiesa che fu completata attorno al 1790. Negli stessi anni la chiesa si arricchisce di una preziosa opera d'arte: una statua in legno di San Giuseppe comprata a Napoli dalla badessa Giovanna Maria Arezzi, che la fece rivestire di lamina d'argento lavorata a sbalzo dall'argentiere messinese Antonio Musolino. Terminata la costruzione della grande volta iniziano a lavorare i maestri stuccatori Giocchino Gianforma di Palermo, Agrippino Magiore di Mineo e Giuseppe Cultrera di Licodia, pagati nel 1793 “per aver fatto la volta di stucco nella nova chiesa del ven. Monastero e per aver fatto certi abbellimenti a tenore del disegno tra essi contraenti fatto”. Lo stesso anno il pittore Sebastiano Lo Monaco “inventò e dipinse” il grande affresco raffigurante la gloria di San Benedetto che domina al centro della maestosa volta, mentre il ragusano Matteo Battaglia dipinse lo “Spirito Santo”, sopra l'altare maggiore, e probabilmente anche il delicato quadro della “Sacra Famiglia con le ciliegie”, posto in fondo all'abside. Nel 1796 la chiesa poteva dirsi ultimata e veniva aperta al culto. Nel 1798 continuarono i lavori di abbellimento con la costruzione del gran coro sopra la porta maggiore e degli otto coretti che si affacciano sulla navata, ideati e realizzati dall'ebanista ragusano Ippolito Cavalieri; da essi le monache potevano assistere alle funzioni senza essere viste dai fedeli. Nel 1801 gli altari laterali vengono ornati con tre quadri dipinti dal pittore pa
re Giambattista Muccio viene pagato per aver scolpito i sei capitelli delle colonne e le “statue grandi di San Benedetto e San Mauro e quelle mezzane di Santa Geltrude e Santa Scolastica”; mentre mastro Paolo Cultraro di Scicli veniva pagato per i due vasi barocchi posti dietro le statue grandi. Nel novembre del 1775 un altro sciclitano, artigiano Filippo Scattarelli, viene incaricato di costruire la grata panciuta in ferro battuto, “da situarsi nel finestrone della nuova imperfetta affacciata sopra la porta maggiore della chiesa”. Il bel prospetto veniva completato con l'aggiunta della cella campanaria a tre luci sormontata da una cuspide che porta la croce, probabilmente nel 1783, anno dell'ultimo pagamento fatto a mastro Giambattista Muccio “per il novo edificio della chiesa di detto Monastero”. Nel 1785 don Domenico Monelli, procuratore del Monastero, incarica mastro Mario Occhipinti di portare nella nuova chiesa “tutta quella pietra di tufo necessaria per lo dammuso”. Inizia la costruzione della grande volta a padiglione, “il dammuso”, a copertura della navata ovale della chiesa che fu completata attorno al 1790. Negli stessi anni la chiesa si arricchisce di una preziosa opera d'arte: una statua in legno di San Giuseppe comprata a Napoli dalla badessa Giovanna Maria Arezzi, che la fece rivestire di lamina d'argento lavorata a sbalzo dall'argentiere messinese Antonio Musolino. Terminata la costruzione della grande volta iniziano a lavorare i maestri stuccatori Giocchino Gianforma di Palermo, Agrippino Magiore di Mineo e Giuseppe Cultrera di Licodia, pagati nel 1793 “per aver fatto la volta di stucco nella nova chiesa del ven. Monastero e per aver fatto certi abbellimenti a tenore del disegno tra essi contraenti fatto”. Lo stesso anno il pittore Sebastiano Lo Monaco “inventò e dipinse” il grande affresco raffigurante la gloria di San Benedetto che domina al centro della maestosa volta, mentre il ragusano Matteo Battaglia dipinse lo “Spirito Santo”, sopra l'altare maggiore, e probabilmente anche il delicato quadro della “Sacra Famiglia con le ciliegie”, posto in fondo all'abside. Nel 1796 la chiesa poteva dirsi ultimata e veniva aperta al culto. Nel 1798 continuarono i lavori di abbellimento con la costruzione del gran coro sopra la porta maggiore e degli otto coretti che si affacciano sulla navata, ideati e realizzati dall'ebanista ragusano Ippolito Cavalieri; da essi le monache potevano assistere alle funzioni senza essere viste dai fedeli. Nel 1801 gli altari laterali vengono ornati con tre quadri dipinti dal pittore pa lermitano Tommaso Pollaci, raffiguranti rispettivamente San Mauro, San Benedetto e Santa Geltrude, e con il quadro raffigurante la Trinità, opera del pittore Giuseppe Crestadoro. Per ultimi vengono realizzati gli altari in pietra bianca ricoperta di “cristalli pittati”: quelli dall'altare maggiore sono opera del Pollaci e quelli dei laterali dei ragusani Carmelo Cultraro jr. e Corrado Leone. La chiesa si arricchisce anche di arredi sacri che la contraddistinguono, in particolare la cortina di velluto e seta ricamata in oro dalle novizie nella prima metà del 1800 (nelle feste viene posta a coprire l'abside) ed il prezioso ostensorio in argento e rame dorato, opera dell'orefice messinese Giovanni Savoia. Da questa data e per gli anni a seguire non ci sono notizie di successive e significative opere eseguite nella chiesa fino al 1945. Per la verità la chiesa, nel 1931, risulta che sia stata oggetto di opere di restauro sul prospetto, ciò non si evidenzia da documenti scritti, ma da una foto che mostra lo svolgersi contemporaneo dei lavori di restauro sul prospetto della chiesa e quelli per la costruzione dell'edificio comunale eretto al posto di una parte della fabbrica del vecchio monastero. Nel 1945 una Priora del Monastero scrive alla Soprintendenza dell'epoca, segnalando che la chiesa “abbisognava” di diverse riparazioni, essendosi la situazione aggravata a causa di ulteriori danni causati dagli eventi bellici. Alla fine del 1957 vengono stanziati dei soldi per il “restauro e consolidamento” della chiesa di San Giuseppe. In perizia sono previsti cordoli in cemento armato per il concatenamento dei muri perimetrali. Nel 1975 altri soldi vengono stanziati sempre per “restauro e consolidamento”.
lermitano Tommaso Pollaci, raffiguranti rispettivamente San Mauro, San Benedetto e Santa Geltrude, e con il quadro raffigurante la Trinità, opera del pittore Giuseppe Crestadoro. Per ultimi vengono realizzati gli altari in pietra bianca ricoperta di “cristalli pittati”: quelli dall'altare maggiore sono opera del Pollaci e quelli dei laterali dei ragusani Carmelo Cultraro jr. e Corrado Leone. La chiesa si arricchisce anche di arredi sacri che la contraddistinguono, in particolare la cortina di velluto e seta ricamata in oro dalle novizie nella prima metà del 1800 (nelle feste viene posta a coprire l'abside) ed il prezioso ostensorio in argento e rame dorato, opera dell'orefice messinese Giovanni Savoia. Da questa data e per gli anni a seguire non ci sono notizie di successive e significative opere eseguite nella chiesa fino al 1945. Per la verità la chiesa, nel 1931, risulta che sia stata oggetto di opere di restauro sul prospetto, ciò non si evidenzia da documenti scritti, ma da una foto che mostra lo svolgersi contemporaneo dei lavori di restauro sul prospetto della chiesa e quelli per la costruzione dell'edificio comunale eretto al posto di una parte della fabbrica del vecchio monastero. Nel 1945 una Priora del Monastero scrive alla Soprintendenza dell'epoca, segnalando che la chiesa “abbisognava” di diverse riparazioni, essendosi la situazione aggravata a causa di ulteriori danni causati dagli eventi bellici. Alla fine del 1957 vengono stanziati dei soldi per il “restauro e consolidamento” della chiesa di San Giuseppe. In perizia sono previsti cordoli in cemento armato per il concatenamento dei muri perimetrali. Nel 1975 altri soldi vengono stanziati sempre per “restauro e consolidamento”.La perizia redatta per la fatiscente copertura testimonia come ne sia stato variato lo schema statico, infatti, “gli arcarecci sono poggianti su due muri in pietrame trasversali che insistono direttamente sulla volta con gravi conseguenze statiche per questa ultima.” Sembra che ci fossero lesioni vistose sulla superficie della cupola e specialmente negli archi di trionfo. Nel 1997 viene dato incarico di predisporre un progetto di manutenzione straordinaria con l'indicazione in particolare di verificare la struttura della copertura a tetto eliminando la spinta senza l'uso di tiranti in vista e sostituendo la struttura in acciaio realizzata nel dopoguerra. Oggi, è certo, che a causa di una non accurata e costante opera di manutenzione nel tempo, la chiesa ha accumulato e ha rivelato dei fenomeni di degrado e fessurazioni, localizzati nella sua imponente facci
 ata, che non possono non essere guardati con attenzione e studiati, per mettere in opera interventi veramente efficaci e risolutivi. L'attuale intervento progettuale ha lo scopo di apportare un miglioramento statico della facciata, un consolidamento e ripristino degli intonaci della volta principale, della volta d'ingresso e della volta del coro, il restauro delle superfici lapidee e le opere di manutenzione straordinaria degli infissi e della grata finestra del coro. Prevista anche l'impermeabilizzazione del terrazzo del campanile e del terrazzino a fianco del coro prospiciente su Piazza Pola. Le opere di recupero e di restauro conservativo della parti lapidee si svilupperanno secondo il susseguirsi di tecniche di intervento che prevedono la pulitura, il restauro, il consolidamento e la finitura di protezione. La chiesa nel suo sistema strutturale si presenta nel complesso staticamente solida e compatta, pur tuttavia all'interno di questo sistema strutturale e compositivo, il “sottosistema” della facciata si mostra relativamente fragile. Ma vediamo come si presenta la partitura della facciata. Quattro pilastri e quattro colonne, caratterizzate da una vistosa rastremazione verso le basi e verso i capitelli e poste su alti basamenti, dividono il prospetto in tre partiti. I due laterali hanno soltanto il primo ordine e terminano con due statue affiancate a grandi volute. Il partito centrale, convesso, ha due ordini, uno termina con un timpano spezzato sopra il quale si trova la cella campanaria a tre luci, sapientemente inglobata da un soprastante, elegante ed agile fregio barocco.
ata, che non possono non essere guardati con attenzione e studiati, per mettere in opera interventi veramente efficaci e risolutivi. L'attuale intervento progettuale ha lo scopo di apportare un miglioramento statico della facciata, un consolidamento e ripristino degli intonaci della volta principale, della volta d'ingresso e della volta del coro, il restauro delle superfici lapidee e le opere di manutenzione straordinaria degli infissi e della grata finestra del coro. Prevista anche l'impermeabilizzazione del terrazzo del campanile e del terrazzino a fianco del coro prospiciente su Piazza Pola. Le opere di recupero e di restauro conservativo della parti lapidee si svilupperanno secondo il susseguirsi di tecniche di intervento che prevedono la pulitura, il restauro, il consolidamento e la finitura di protezione. La chiesa nel suo sistema strutturale si presenta nel complesso staticamente solida e compatta, pur tuttavia all'interno di questo sistema strutturale e compositivo, il “sottosistema” della facciata si mostra relativamente fragile. Ma vediamo come si presenta la partitura della facciata. Quattro pilastri e quattro colonne, caratterizzate da una vistosa rastremazione verso le basi e verso i capitelli e poste su alti basamenti, dividono il prospetto in tre partiti. I due laterali hanno soltanto il primo ordine e terminano con due statue affiancate a grandi volute. Il partito centrale, convesso, ha due ordini, uno termina con un timpano spezzato sopra il quale si trova la cella campanaria a tre luci, sapientemente inglobata da un soprastante, elegante ed agile fregio barocco.Nel primo ordine al termine di una breve scalinata, che si diparte dal sagrato, si apre il portone d'ingresso decorato da un fregio a motivi vegetali; nel secondo ordine, in asse con il portone di ingresso, è posta una finestra anch’essa finemente ornata e decorata. Il punto di fragilità statico-strutturale è costituito proprio dalla composizione dei tre partiti di cui quello centrale, convesso e slanciato, è il più leggero e costituisce il partito meno solido staticamente di fronte ad eventuali azioni di assestamento del terreno o ad eventuali azioni sismiche, pur essendo sostenuto dagli altri due partiti posti lateralmente a modo di contrafforti di sostegno e serrato dal peso dell'insieme della cella campanaria e del fregio. Tale fragilità è anche “assecondata” da una struttura muraria non priva di segni di debole compattezza. Il miglioramento statico della facciata sarà conseguito con interventi “minimali”, non invasivi, non fortemente impattanti, in linea con le indi
 cazioni fornite dal contemporaneo dibattito sul restauro.
cazioni fornite dal contemporaneo dibattito sul restauro.L'intervento proposto è teso a migliorare la resistenza della struttura muraria senza apportarvi modifiche consistenti e con mezzi compatibili e soprattutto reversibili, lasciando inalterato lo schema statico strutturale, anzi operando nel senso di un suo irrobustimento. Le indagini diagnostiche hanno fornito quei dati necessari e sufficienti per valutare il comportamento statico del complesso strutturale del monumento storico. Le risultanze inducono a ritenere che non ci sono problemi in fondazione, così come, dall'analisi dei carichi e dal comportamento consequenziale, si può escludere la presenza di una patologia in atto che minaccia il monumento nella sua facciata. Si può dire che i “danni” concentrati nella facciata curva sono danni “antropici”, causati da una realizzazione poco corretta (vedi messa in opera dei conci di calcare non ben ammorsati tra loro, con le linee dei giunti sfalsate, qualità modesta dei materiali utilizzati per le murature interne formate da conci di forma eterogenea e con presenza di modeste cavità) ed attribuibili anche ad avvenimenti esterni, quali eventi sismici, vibrazioni da traffico urbano, soprattutto pesante. Le indagini e le informazioni delle tecniche costruttive delle murature del monumento ci dicono che esse sono costituite generalmente da murature a due facce, quella interna in pietrame rifinita con intonaco a calce, quella esterna con blocchi di calcare tenero compatto a pelle liscia lasciata a vista. La compartecipazione statica strutturale delle due murature è data dalle ammorsature di blocchi di calcare della facciata che si inoltrano nella muratura interna in pietrame e dalla qualità costruttiva delle due murature. La debolezza di una muratura, e quindi la comparsa di lesioni più o meno gravi, dipende dalla non corretta osservanza di queste elementari tecniche costruttive, come nel caso della chiesa di San Giuseppe. La scarsa compattezza delle murature interne contribuisce al sorgere di tali fenomeni, per cui, per bilanciare l'effetto ribaltamento che si manifesta nella facciata curva ci appare corretta l'idea di “cinturare” la facciata con due cerchiature in acciaio inox, posizionati in modo tale da non essere percepiti dal punto di vista del visitatore ed in corrispondenza, una, del cornicione del primo ordine e l'altra del secondo ordine.
Tale intervento deve essere preceduto da un irrobustimento delle murature interne, per ridare compattezza alla struttura e ricostruire quella omogeneità e robustezza che non le è stata data in origine.










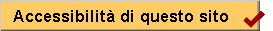
Aggiungi questo link su: