
Ragusa Sottosopra - Anno XII - N° 2
Beni mobili
L'organo maximum della Chiesa Madre di San Giorgio
Gli organari Serassi e la loro opera massima. Unica al mondo1° parte
Sugli organi della città di Ragusa non esiste uno studio né autonomo né collegato a più vaste indagini riguardanti lo
sviluppo delle attività musicali durante gli ultimi tre secoli. La ricerca è resa quasi impossibile dalla rarità delle fonti
di informazione che sono quasi sempre occasionali e indirette. Nel volume di Salvatore Appiano “Gli Organi della Diocesi di
Ragusa” vi è l’elenco degli strumenti, e dalla data della sua pubblicazione ad oggi si sono acquisite altre notizie.
Sul panorama musicale della città, unico squarcio nel buio è costituito dal manoscritto
(inedito) del dr. Filippo Pennavaria, quando la musica, sul finire dell’800, era in declino nelle grandi famiglie dove erano
presenti clavicembali, violini, violoncelli atti ad eseguire musica da salotto.
Prima del terremoto del 1693 riguardo agli organi le notizie sono desunte dalle note spese per l’organista e il tiramantici,
nonché per le feste patronali, sia di San Giorgio che di San Giovanni. Venivano addobbate le chiese al cui interno vi era un
palco e vi si svolgevano trattenimenti musicali sotto forma di inni, cantate e ovviamente vespri e messe solenni. Negli
ottavari antecedenti alle feste si rappresentavano addirittura operette e opere in musica e in prosa con intervalli musicali; a quei tempi gli unici spazi che potevano surrogare un teatro erano le chiese. Le processioni erano accompagnate da
tamburini, pifferi e trombette. Cantori e musicisti venivano fatti venire da paesi limitrofi e oltre al salario pattuito si dava loro vitto e alloggio.
La situazione non fu molto differente dopo il terremoto che distrusse organi, strumenti musicali e spartiti, senza
contare che un gran numero di libri e di carte venne bruciato dalla popolazione per scaldarsi in quell’inverno rigido, con
le case distrutte o inagibili. Si salvarono quei documenti, per lo più legati alle chiese, riguardanti atti di proprietà o di diritti.
Erano le feste patronali animate da un esasperato campanilismo a sopravanzare per importanza ogni altro avvenimento
cittadino: le spese per questi trattenimenti musicali erano considerate “necessarie”, segnando il massimo dell’impegno di
tutti i ceti sociali, ma dando nello stesso tempo il limite culturale della città, nella quale i dissidi religiosi erano
spinti sino al fanatismo dalla classe sacerdotale, sovente non autoctona, troppo numerosa, la quale dava spettacolo della sua partigianeria e della sua pochezza spirituale.
Di tutti gli organi seicenteschi che dovevano essere nella città rimane solo quello dell’Annunziata (foto1), di quelli che si trovavano nell’antica San Giorgio e nell’antica San Giovanni non si conoscono gli autori. A San Giovanni risulta un
“organetto” nella cappella maggiore costato 20 onze, e uno “grande” del quale nell’ottobre 1667 si registra la spesa per
farlo accordare. Spese per l’ organista e per il tiramantici risultano pure a San Giorgio. In ambedue le chiese vi era un
“corpus di musici concertati e obbligati a cantare di canto figurato nelle festività”. Considerando che le comunicazioni a
quei tempi erano difficili, che il trasporto di grandi strumenti era difficoltoso, questi organi di cui si ha notizia erano
pochi e di modeste dimensioni. Il periodo post terremoto, trascorsi i primi anni durante i quali si ricostruirono gli edifici e le chiese, diede alla città un numero di organi più che notevole. Primo tra tutti l’importantissimo organo di Frà Francesco Bombace (foto 2), carmelitano di Caltanissetta, posto nella chiesa di San Francesco all’Immacolata datato 1704 che è l’unico pervenuto integro. A San Vincenzo Ferreri vi era un altro organo; di quello di S. Maria di Gesù (foto 3 e 3 bis) sino a qualche anno fa esisteva la cassa e qualche canna, oggi disperse: tutti ne abbiamo ricordo perché nel film “Divorzio
all’italiana” vi si celebra il matrimonio di Paolo e Rosalia e il regista Pietro Germi nel 1961 riprende la cassa dell’organo posto nella controfacciata.
Quello di Santa Maria delle Scale del 1730 è del siracusano Agatino Santucci, un altro ancora è a Santa Maria
dell’Itria (foto 4 e 4 bis), nel quale, oltre alla firma di Giacomo Andronico sul somiere principale, tutte le canne di
facciata sono di Frà Francesco Bombace del quale portano il punzone, e che evidentemente sono canne di spoglio provenienti
da un altro strumento. Un altro del siciliano Platania si trova nella chiesa di San Giuseppe (foto 5), e appartiene alla seconda metà del Settecento.
L’ultimo della serie è quello che si trovava nella chiesa di Santa Maria La Nova, anch’esso di Agatino Santucci del
1730 (foto 6) e che oggi si trova nella Chiesa Madre di San Giorgio a lato della cappella del SS. Sacramento.
Nella cattedrale di San Giovanni Battista vi era un organo (la cui cantoria faceva anche da pulpito) situato nel lato
sinistro nel quinto intercolumnio la cui posizione risulta chiaramente dalla pianta del 1742 con la disposizione dei banchi assegnati alle famiglie per le prediche quaresimali.
Anche nella Chiesa Madre di San Giorgio vi era l’organo che fu venduto ai Frati Conventuali nel 1786 per far posto a
quello di Giacomo Andronico trasportato poi nella chiesa del Purgatorio.
Tra questi due strumenti doveva esservi una grande disparità. Quello di San Giovanni, occasionalmente fuori uso, fu
sostituito per la prima volta nel 1841 da una filarmonica (quella famosa dei Pennavaria). Le esibizioni di questa
filarmonica nella chiesa di San Giovanni avvennero più volte e in occasioni diverse. Evidentemente, il primo organo post
terremoto non era più all’altezza della grande chiesa che lo ospitava per cui nella seconda metà dell’800, prima delle
leggi di soppressione dei beni ecclesiastici, San Giovanni fa il salto di qualità: si rivolge alla grande famiglia
bergamasca dei Serassi che allora erano i più rinomati fabbricanti italiani di organi. Il nome di uno strumento Serassi
era sinonimo di prestigio, di qualità e di bellezza.
Singolare storia quella di questa grande famiglia che per oltre due secoli dominò il panorama italiano nel campo della
costruzione di organi. I loro strumenti segnarono il passaggio della musica strettamente liturgica a quella grandiosa
ottocentesca in cui l’organo divenne orchestra, coro e voce solista, consentendo al grande pubblico di conoscere le musiche dei grandi compositori italiani.
Il capostipite della ditta fu Giuseppe (I) (1693-1760) nato a Cardano nella Pieve di Grandola in Valmenaggio (Como).
Dei suoi sei figli solo Andrea Luigi continuò a fabbricare organi, ma la casa si affermò definitivamente con il figlio di
Andrea, Giuseppe (II), organaro di grande genio che arricchì la sua fabbrica, trasferita a Bergamo, con invenzioni
originali e innovative delle vecchie meccaniche e dei sistemi di trasmissione. Anche lui ebbe sei figli, tutti organari, ma
è soprattutto Carlo (1777-1849) a conquistare una fama mondiale. Gli organi fabbricati dalla “Imperial Regia Fabbrica
privilegiata di Bergamo” diventano uno “status symbol” e sinonimo di eccellenza.
Alla morte di Carlo, il fratello Giacomo, coadiuvato dai nipoti Giuseppe (IV), Carlo (II) e Vittorio, continua l’attività e costruisce, principalmente nel nord e nel centro Italia, centinaia di strumenti con l’aiuto di operai qualificati tra i
quali Giacomo Locatelli e il capo fabbrica Casimiro Allieri (1848-1900).
All’inizio dell’ ‘800 è gerente della fabbrica il napoletano “ragioniere” Giovan Battista Castelli, autore di un
catalogo degli organi Serassi aggiornato al 1868. Ma la ditta, in mano a Ferdinando, è ormai arrivata all’apogeo e intorno
al 1860 iniziano i segni di crisi. Giacomo Locatelli e altri operai si mettono in proprio. Nella seconda metà del XIX
secolo Ferdinando (II), probabilmente per opera del Castelli che procura le commesse, arriva in Sicilia. Il Castelli
doveva conoscere bene la Sicilia che ancora faceva parte del Regno delle Due Sicilie (1816-1861); tutti i grandi prelati e i nobili per un motivo o per un altro avevano rapporti con Napoli, fu perciò facile per il Castelli contattare questi
potenziali committenti e fare conoscere gli strumenti Serassi.
Come il barocco ha concluso la sua stagione nella Sicilia sud-orientale regalando al mondo opere grandiose e uniche, così
la fabbrica Serassi chiude il suo ciclo vitale nella nostra isola, fabbricando uno strumento grandioso e unico, l’Organum Maximum della Chiesa Madre di San Giorgio, applicandovi tutte le innovazioni e le invenzioni sviluppate nel corso di due
secoli dai più geniali componenti della famiglia. Queste innovazioni ebbero origine dall’ampia ricerca di effetti sonori a
cui tutta l’arte organaria lombarda tendeva già dalla fine del Settecento. Artigiani organari insigni quali i Bossi, i
Sangalli, i Lingiardi, gli Amati, ed ovviamente anche i Serassi, che avevano raggiunto una maestria ed una abilità senza
pari, danno vita ad un fenomeno tutto italiano che non ha riscontro in nessuna altra parte del mondo. All’organo liturgico
di accompagnamento dei cori, e deputato ad eseguire musiche chiesastiche, viene aggiunta tutta una serie di registri che
imitano gli strumenti di un’orchestra. Nascono così organi che rispecchiano mirabilmente il gusto musicale dell’Ottocento, progettati e costruiti per eseguire anche brani operistici o sinfonici. Trombe, viole, fagotti, corni inglesi, flauti,
ottavini, e registri ad effetti speciali come campanelli, uccelliere, sistri, grancasse e altri ancora, entrano a far
parte del corredo dello strumento.
L ’organo, così concepito, dà un contributo fondamentale alla diffusione della vasta letteratura musicale italiana,
facendo conoscere alla gente comune il repertorio operistico dei grandi compositori. La chiesa diventa teatro e l’organo
palcoscenico, da cui si diffondono le melodie (trascritte per l’organo) delle opere più note e amate. Bellini, Verdi,
Rossini, Donizzetti, Puccini diventano così nomi conosciuti anche dal grande pubblico che, ai tempi, non aveva certo la
possibilità di frequentare i teatri.
Da questo fenomeno nasce la competizione tra San Giorgio e San Giovanni: ognuna delle due chiese ha cercato di
superare l’altra. Risultato: Ragusa oggi è la città che possiede capolavori unici ed inimitabili di cui possiamo essere
orgogliosi, e per i quali dobbiamo essere grati ai Serassi.
Autore: Andrea Ottaviano
Commissione Risanamento Centri Storici:
Opinioni a confronto:
L'opera:
Il recupero:
Lavori in corso:
Palazzi storici:
Ambiente:
Itinerari:
Beni mobili:
Congressi:



















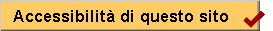
Aggiungi questo link su: