
Ragusa Sottosopra - Anno XII - N° 3
La pubblicazione
Le elezioni in provincia di Ragusa (1946 - 2011)
Nel volume “Le elezioni in provincia di Ragusa” (1946-2011), curato da Francesco Raniolo e Maurizio Cerruto, vengono ricostruite, attraverso una elaborazione sistemica dei dati, le vicende elettorali (anche referendarie) di tutta la storia repubblicana nella provincia iblea restituendo uno spaccato complesso e variegato della storia non solo politica del territorio, ma anche sociale ed economica, e rilevando le interazioni più evidenti con ambiti più allargati (dal locale al globale). Numeri, date, dinamiche, variabili, incidenze, fattori, congiunture sono gli ingredienti che costruiscono il percorso del libro, prezioso strumento per chi vuole avere un quadro dettagliato ed una visione d’insieme del gioco democratico che si è sviluppato in questi 60 anni e più nella nostra provincia tra corpo elettorale e rappresentanze politiche. Abbiamo incontrato uno dei curatori, il prof. Francesco Raniolo, per approfondire alcuni aspetti della pubblicazione realizzata con il sostegno della Banca Agricola Popolare, della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania e dalla Provincia regionale di Ragusa.
Prof. Raniolo la genesi di questo libro nasce nelle aule universitarie. Ci racconta come?
Beh, nel modo normale in cui dovrebbe funzionare l’Università (almeno dal mio punto di vista). C’era l’idea forte da parte del Corso di laurea in Scienze del Governo di radicarsi e avere una presenza di qualità nel territorio in forme svariate: gli
stage degli studenti, i seminari e gli incontri con le imprese e gli attori istituzionali della provincia, ma anche attraverso
gli insegnamenti (penso a Storia del Territorio) e, quindi, le tesi di laurea. Quando ci siamo accorti che gli studenti erano molto interessati a tesi di ricerca e di documentazione (e non solo nell’area politologica) ci siamo chiesti quale poteva essere il modo per valorizzare il loro lavoro. La prima cosa da fare ci è sembrata la costituzione di un “Osservatorio sulla politica
locale” dove raccogliere queste tesi e dal quale magari trarre qualche pubblicazione. E siamo arrivati al nostro libro: dedicare una pubblicazione alla storia elettorale della provincia di Ragusa nell’età repubblicana. L’idea nacque molti anni fa, nel 2007 (prima che io andassi via dall’università di Catania) e ci sono voluti un po’ di anni per realizzarla.
Quale approccio metodologico sta alla base del lavoro prodotto?
La prospettiva che ha ispirato il lavoro è quella della “comprensione primaria” (o descrizione), cioè la raccolta puntuale e sistematica dei dati di un certo fenomeno (in questo caso il comportamento elettorale nei suoi diversi aspetti: affluenza alle urne, voti nulli e schede bianche, voti validi) al fine di costituire un data-set che potesse essere utile per ulteriori studi a carattere più esplicativo (comprensione secondaria) o addirittura previsionale (per esempio ai fini di marketing elettorale).
La rilevazione è stata poi sistematica: ha riguardato i 12 comuni della provincia, per tutti i livelli istituzionali in cui si è votato (esclusi i consigli di circoscrizione), comprensivi tanto delle elezioni di prim’ordine (quelle politiche) che quelle di secondo ordine (regionali, provinciali, comunali, europee e referendum). Il tutto per oltre sessant’anni e ha riguardato
complessivamente oltre 80 elezioni.
Inoltre, da un punto di vista sostantivo, il nostro costituisce un lavoro di ecologia elettorale (cioè di dati raccolti
per area geopolitica) che presentano una marcata specificità rispetto a traiettorie e dinamiche di voto regionali o nazionali.
Se c’è una specificità del voto ibleo questa andrebbe spiegata con fattori di contesto, con la storia dell’area iblea e con i
protagonisti che ivi si sono mossi. Una storia elettorale è solo una delle tante “storie” che descrivono e ci raccontano un
territorio.
Che tendenze possono essere desunte dalla “storia” che viene fuori dalla supervisione di tutti i dati raccolti e quali le comparazioni più interessanti?
Questo forse è l’aspetto più interessante (sotto il profilo scientifico) della raccolta di dati statistici sulle elezioni
che abbiamo condotto. Negli annali di storia elettorale la provincia di Ragusa è stata considerata come una realtà deviante (nel senso statistico) rispetto al quadro regionale siciliano. Una zona di sinistra, dove era forte una “quasi-subcultura” rossa. Cosa c’era di vero in questa immagine, come si è mantenuta o è mutata nel tempo e poi che varianza mostrava a livello
infra-provinciale: la nostra raccolta ha consentito di rispondere a questi e ad altri interrogativi. Tra le tendenze più
rilevanti ne possiamo richiamare alcune. Innanzi tutto, nel corso del tempo l’elettore ibleo è diventato meno civico, meno partecipativo, ha scelto sempre di più di assentarsi dalle urne. Nel 2008 la partecipazione elettorale è scemata a poco più del
75% (media provinciale), questo dato è ancor più preoccupante se aggiungiamo la percentuale delle schede bianche e dei voti
nulli, arriviamo così a quasi il 30% e oltre (a livello europeo) di “voto inespresso”. Le nostre sono sempre di più democrazie
senza demos. Il che pone problemi interpretativi agli studiosi e pratici ai politici.
Ma più interessante è l’andamento dei voti validi ai partiti. Se guardata nel lungo periodo la provincia di Ragusa sembra perdere la sua specificità (che a dire il vero in città come Ragusa o Modica non aveva mai attecchito) data dal profilo politico “rosso”; negli ultimi dieci quindici anni l’identikit ideologico-politico della provincia appare via via più sbiadito, meno rosso ma anche meno blu (anche le roccaforti democristiane segnalano smottamenti). Ma alla fine del periodo da noi considerato il quadro sembra mutato; adesso l’area degli iblei mostra una caratterizzazione più marcatamente di centro-destra.
Basta guardare al livello delle giunte comunali (prima delle ultime elezioni dello scorso maggio); nel ciclo elettorale
2005-2008 nove comuni su dodici vanno al centro-destra (fanno eccezione Giarratana, Monterosso e Vittoria). Certo, adesso che
tutto è nuovamente in movimento e che il 2013 sembra presagire un sistema partitico con protagonisti nuovi e alleanze inusitate,
resta comunque il dato di una tendenza moderata dell’elettorato della nostra provincia, almeno fino a ieri.
In che misura possono essere prevedibili (ammesso che lo siano) i comportamenti elettorali?
La previsione nelle scienze sociali non sono una “cosa” semplice e a portata di mano. I fenomeni sociali sono “nuvole” difficili da afferrare, non sono “orologi” più o meno precisi (la metafora è di Popper).
Di solito la previsione dei fenomeni presuppone che questi mostrino una certa regolarità e nel passato era più facile cogliere dinamiche e tendenze. I risultati di un’elezione dipendono da tre cose: il sistema elettorale, l’offerta politica (i partiti in
campo e le loro proposte) e la domanda degli elettori (come si comportano questi ultimi). Ora, negli ultimi due decenni ed
oltre, tutti e tre questi aspetti sono diventati incerti: le leggi elettorali sono cambiate più volte, i partiti e le alleanze
si compongono e ricompongono continuamente secondo una sorta di “ballo di San Vito” senza fine, gli elettori sono diventati più
volatili, cambiano spesso il referente del proprio voto, e sono anche più intermittenti, decidono di alternare partecipazione e
astensione. Anzi, come mostrano i nostri dati, l’astensionismo è cresciuto molto ed è destinato a crescere ancora. L’unica cosa
che possiamo dire è che il mercato elettorale locale è diventato, seguendo dinamiche già note a livello nazionale, sempre più turbolento. Se sarà sempre così? Credo ancora per parecchio tempo.
Leggendo il siglario delle liste emerge la forte frammentarietà della rappresentanza politica
(personalmente sconoscevo l’esistenza del Blocco Democratico Liberal Qualunquista!).
Come è mutato questo aspetto nel tempo, tra prima e seconda repubblica?
La politica, tanto più a livello locale, ha sempre mostrato una certa fantasia. Molte delle liste che si presentavano alle elezioni in realtà erano destinate a durare poco (si trattava di cosidetti “partiti flash”) o, addirittura, non riuscivano a sopravvivere alla tornata elettorale del momento. In verità, dal dopoguerra alla fine degli anni ’80, il formato del sistema
partitico locale e nazionale ha sostanzialmente riprodotto lo “stampo originario”; i partiti sopravvissuti alle prime elezioni
del dopoguerra li ritroviamo ancora in sella trent’anni dopo: Pci, Psi, Psdi, Pri, Pli, Dc, Msi. Gli altri sono “partiti irrilevanti”, nel senso di Sartori, cioè che non hanno potenziale di governo e non sono in grado di influenzare il quadro
politico. Lo scenario cambia negli anni ’90 quando il vecchio sistema partitico si destruttura e si afferma un sistema nuovo
che, a vent’anni di distanza, continua ad essere fluttuante e preda di spinte centrifughe. Il che è un problema serio per la
qualità della nostra democrazia, tanto a livello locale che nazionale. A livello locale poi in questi ultimi decenni è cresciuto oltremodo il fenomeno delle liste civiche nelle svariate forme (localistiche, strategiche o di disturbo, personali), ma anche
questo ci racconta di un quadro politico che è diventato una “maionese impazzita”, sempre in fieri e mai in essere. Chissà forse in una società liquida la politica non può che essere altrettanto fluida. Una “politica blob”.
Fenomeni come “il voto di scambio” possono essere ricavati dal linguaggio dei numeri?
La risposta è si e no. Partiamo dal NO; il voto di scambio rimanda alle motivazioni e più in generale alla struttura del rapporto che lega gli elettori ai partiti e ai politici (sindaci, presidenti, governatori, ecc.). Le motivazioni, come nel caso del voto di appartenenza o di opinione, si possono desumere solo da dati di sondaggio, ovvero dalle inchieste di opinione pubblica allorquando si chiede più o meno direttamente all’intervistato il perché ha votato in un certo modo. Per contro, le motivazioni non si possono ricavare direttamente dai dati ecologici, che al riguardo sono muti. Tuttavia, e siamo arrivati al SI, dai dati ufficiali si possono riferire con una certa circospezione alcuni “indizi” che assieme ad altri aspetti
rappresentano la probabilità che si verifichi un certo tipo di comportamento.
Provo a chiarire. Per esempio, c’è un fenomeno che si chiama “effetto giunta” nel senso che a livello delle elezioni comunali tendono ad essere premiati i partiti di governo (nazionale), rispetto a quelli all’opposizione; o, ancora, si può considerare il cosiddetto voto differenziato per un partito tra il livello delle politiche e quello delle amministrative; o
ancora si può guardare all’astensionismo selettivo, cioè alla differenza tra l’affluenza alle urne ai referendum e alle
politiche o, addirittura, alle comunali. Ebbene tutti questi possono costituire indizi di voto di scambio, cioè di un
orientamento particolaristico degli elettori rispetto alla politica. Un altro indicatore efficace è dato dal ricorso al voto di
preferenza e dalla distribuzione delle preferenze all’interno delle liste (fino al 1991 questo indicatore ci diceva molte cose
sulla struttura dei rapporti tra cittadini e partiti), alti tassi di preferenza e la loro dispersione sono indicatori di un
orientamento particolaristico (di un voto ad personam) che può veicolare anche (ma non solo) scambio clientelare.
Francesco Raniolo è professore ordinario di Scienza della Politica e Presidente del corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione presso l’università della Calabria. Fa parte del Comitato direttivo della Società Italiana di Scienza Politica.
Maurizio Cerruto è ricercatore presso l’università della Calabria, dove insegna Scienza
dell’Amministrazione. Svolge attività di ricerca sui temi del governo locale e della rappresentanza politica nelle regioni italiane.
I testi della pubblicazione sono di: Rita Albergamo, Antonella Aprile, Rosario Aprile, Elisa Bellassai, Michele Caccamo, Domenica Celestre, Maurizio Cerruto, Gianfabio Chillè, Concetta Criscione, Floriana Flamingo, Maria Carmela Martorana, Lucia Montesanti, Daniela Napoli, Rosario Nobile, Antonella Occhipinti, Francesco Raniolo, Marina Sgarlata, Salvatore Vinci.
Intervista a cura di: Faustina Morgante
Opinioni a confronto:
Il progetto:
Regolamenti:
Inaugurazioni:
Ricorrenze:
Ragusani illustri:
Beni mobili:
La pubblicazione:
L'evento culturale:
Lettere in redazione:






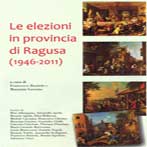









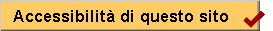
Aggiungi questo link su: